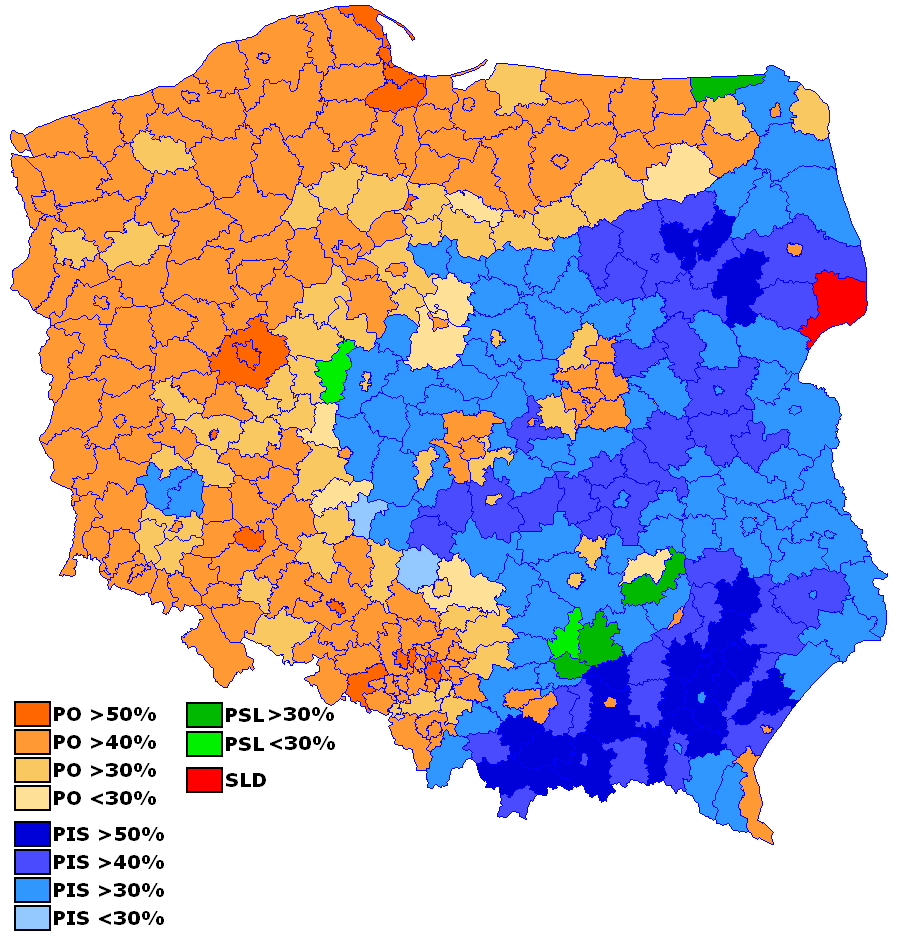Pubblicato il 17 settembre 2011 su East Journal
UE: come reagire alla primavera araba e al riconoscimento della Palestina?
Le
rivolte democratiche nei paesi arabi sono state seguite da uno appello alla creatività, da parte dell’Europa, per sostenere e ancorare alla democrazia e ai diritti umani i nuovi regimi della sponda sud. L’UE ha risposto in maniera sostanzialmente
reattiva, e nonostante i risultati della guerra in Libia, la sua immagine è rimasta
appannata. Il mese di settembre, con la sessione ONU che valuterà del
riconoscimento internazionale dello stato di Palestina, pone una nuova
sfida alla diplomazia europea, che ancora una volta appare presa in contropiede e
senza una posizione comune.
Già in febbraio,
Bill Emmott aveva fatto appello perché l’Unione Europea aprisse le sue porte alle nuove democrazie mediterranee, idea ripresa
su Libération per quanto riguarda la Tunisia. Ma un tale salto in avanti, dall’attuale labile rapporto di vicinato ad una ferma prospettiva di allargamento, appare irrealistico nel breve periodo.
Una simile prospettiva di
allargamento dell’UE a sud-sud-est, a fini di ancoraggio democratico, era già stata
proposta dal Partito Radicale, nel 1988, come percorso di risoluzione del conflitto israelo-palestinese.
Rilanciata da Berlusconi in una sua
captatio benevolentiae a Gerusalemme nel 2010, il tema è rimasto sottotraccia nella maggior parte delle opinioni pubbliche europee, e non ha d’altra parte sortito alcun passo concreto da parte del governo di Tel Aviv.
Ma se
l’adesione all’UE rappresenta un passo troppo lungo, una opportunità più concreta è fornita da quell’altra organizzazione internazionale, la cui creazione ha preceduta di un decennio la CEE, e che detiene i diritti d’autore sulla bandiera blu a dodici stelle. Si tratta del meno conosciuto
Consiglio d’Europa, fondato nel 1949 e che raggruppa oggi
47 stati, da
Finisterre a Vladivostock, inclusi tutti gli stati post-sovietici con la sola eccezione della Bielorussia autoritaria. Il
Consiglio d’Europa ha fatto della
protezione dei diritti umani la sua cifra identitaria, attraverso la firma obbligatoria per i suoi stati membri della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Il rispetto della Convenzione è garantito dalla
Corte CEDU di Strasburgo, a cui ciascuno degli 800 milioni di cittadini degli stati membri (ma anche qualunque straniero sottoposto alla loro giurisdizione) possono fare direttamente appello, una volta terminati i possibili ricorsi interni.
Ma come potrebbe l’UE spingere all’adesione al Consiglio d’Europa i propri paesi vicini? In effetti, l’Unione ha in atto con la maggior parte dei Paesi Partner Mediterranei (PPM) degli Accordi Euro-Mediterranei di Associazione (AA), entrati in vigore in vari momenti tra il
1998 (Tunisia) e il
2006 (Libano); solo Libia e Siria ne sono rimaste finora sprovviste. Tali accordi riportano una clausola tipica di “elemento essenziale”, all’art.2:
Relations between the Parties, as well as all the provisions of this Agreement itself, shall be based on respect of democratic principles and fundamental human rights as set out in the Universal Declaration on Human Rights, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement. [Accordo UE-Libano]
Il riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, inserito negli accordi più recenti come chiave di interpretazione di ciò che si intende per rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, rende possibile un legame con il Consiglio d’Europa e la Convenzione Europea dei Diritti Umani. Quest’ultima infatti, come espresso da Pierre-Henri Teitgen (Au sources de la Cour et de la Convention européenne des droits de l’homme, coll. Voix de la cité, Confluences, Bordeaux 2000), si proponeva di riprendere le garanzie più fondamentali tra quelle riportate nella Dichiarazione ONU, sottoponendole ad un controllo giurisdizionale che potesse nel tempo portare alla creazione di un sistema europeo di protezione dei diritti dell’uomo.
Opportunità dell’allargamento del Consiglio d’Europa
Il Consiglio d’Europa offre maggiori garanzie di flessibilità, rispetto all’UE, per una progressiva integrazione di Israele e delle nuove democrazie mediterranee:
1- In quanto organizzazione specializzata in un campo specifico, offre minori resistenze da parte di stati già membri che potrebbero avere forti remore su altri dossier di competenza dell’UE (politiche agricole, etc);
2- Il Consiglio d’Europa ha, sin dal suo inizio al congresso dell’Aja del 1948, spinto per una versione estesa del concetto di Europa, invitando al dibattito da subito la Russia e la Turchia (ma anche la Gran Bretagna), ed allargandosi successivamente fino al Caucaso meridionale; un eventuale allargamento ad Israele e alle altre democrazie mediterranee sarebbe fattibile, per quanto innovativo;
3- La partecipazione di Israele e delle altre democrazie mediterranee alla CEDU, col suo focus privilegiato sui diritti umani, potrebbe costituire un importante test della volontà di tali governi di garantire lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali ai propri cittadini e agli stranieri sotto la propria giurisdizione;
4- Con la progressiva integrazione tra i sistemi UE e del Consiglio d’Europa di salvaguardia dei diritti umani (l’UE ha
in corso negoziati con il Consiglio d’Europa per accedere alla Convenzione, così come stabilito dal Trattato di Lisbona), l’adesione al sistema di Strasburgo potrebbe divenire una precondizione, da parte dell’Unione, per la concessione dello Status Avanzato nei suoi rapporti di vicinato con i paesi mediterranei; tale status è oggi concesso a Marocco, Giordania e Israele, pur con ben pochi contenuti sostanziali.
Ostacoli
Ciononostante, diversi ostacoli si presentano, ad una prima analisi:
1- Il sistema di Strasburgo è già ora sotto stress, per
mancanza di risorse e di volontà degli stati di far rispettare le sentenze CEDU da parte dei giudici interni. Le recenti proposte di legge,
in Gran Bretagna e
in Russia, volte ad introdurre un controllo successivo di costituzionalità delle sentenze CEDU, costituiscono un segnale preoccupante. Inoltre, le scarse risorse disponibili rendono grave il carico di arretrati da smaltire.
2- La Convenzione include una serie di
diritti umani e libertà fondamentali inderogabili (diritto alla vita, interdizione della tortura, della pena di morte, diritto ad un equo processo, rispetto della vita privata e familiare), a cui si aggiungono tramite Protocolli ulteriori diritti di successiva codificazione, quali il diritto alla proprietà (art. 1 del 1° protocollo). Tali diritti
potrebbero far sorgere problemi particolari per Israele. La giurisprudenza successiva al caso
Loizidou v. Turchia (1996), relativo ai beni dei cittadini greco-ciprioti nel territorio della Repubblica Turca di Cipro Nord,
potrebbe rappresentare un precedente per la richiesta di restituzione o compensazione da parte delle centinaia di migliaia di palestinesi espulsi da Israele o dai territori occupati.
3- Lo stabilimento di relazioni diplomatiche con Israele potrebbe divenire necessario per l’adesione al sistema di Strasburgo da parte delle nuove democrazie arabe; allo stesso tempo, Israele potrebbe verosimilmente non volersi sottoporre ad uno scrutinio sovranazionale della propria legislazione interna, fintanto che permangono le condizioni per cui lo stato ebraico si considera in uno stato di guerra.
Raccomandazioni
Perché il rispetto dei diritti umani divenga un cardine della politica estera di vicinato dell’Unione Europea, e perché Israele e le nuove democrazie mediterranee possano integrarsi nel Consiglio d’Europa, è fondamentale che alcuni passi siano presi.
1- Gli stati membri del Consiglio d’Europa, inclusi Russia, Regno Unito e Turchia, devono impegnarsi a garantire alla Corte di Strasburgo adeguate risorse per lo smaltimento del carico di casi arretrati, e una efficace esecuzione delle sentenze nel diritto interno. L’UE, che diverrà parte della Convenzione nel prossimo futuro, deve fare pressione, sui suoi stati membri e candidati, affinché tali impegni siano portati avanti.
2- La Politica Europea di Vicinato dell’UE deve prendere sul serio la clausola di “elemento essenziale” relativa al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, presente in pressoché tutti gli Accordi di Associazione tra l’Unione e i paesi mediterranei. Ciò può avvenire soltanto attraverso la spinta per l’adesione di tali paesi al Consiglio d’Europa, come precondizione per uno Status Avanzato nei rapporti di vicinato europeo.
3- L’adesione di Israele e delle altre democrazie mediterranee alla Convenzione CEDU potrebbe limitarsi in un primo momento ai diritti e libertà fondamentali, tralasciando le ulteriori clausole in grado di costituire una pietra d’inciampo, quali l’art.1 del 1° Protocollo sul diritto alla proprietà.
4- Per evitare dilemmi di azione collettiva, l’adesione di Israele e degli altri paesi democratici mediterranei (Palestina inclusa) al Consiglio d’Europa dovrebbe far parte di un pacchetto globale, con una chiara road-map, di risoluzione del conflitto arabo-israeliano. Le primavere arabe rappresentano una importante opportunità di rilancio del processo di pace, che non deve essere lasciata sfuggire.
Conclusioni
Una richiesta da parte dell’UE di entrare a far parte del Consiglio d’Europa e di mettere in pratica la Convenzione Europea dei Diritti Umani costituirebbe così un rafforzamento della politica di condizionalità, dando finalmente significato alla clausola di elemento essenziale degli accordi di associazione. Le relazioni dell’UE con i vari dittatori, da Ben Ali a Mubarak, ha già fatto troppi danni all’immagine e alla credibilità del soft power continentale. Chiedendo ai paesi vicini di entrare a far parte del club di Strasburgo, l’UE dimostrerebbe di prendere sul serio la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali nei paesi vicini.
 Pubblicato su EastJournal, 24 ottobre 2011
Pubblicato su EastJournal, 24 ottobre 2011